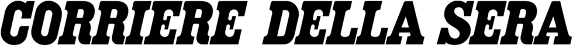Da Sanremo un sussulto di dignità
di Tito Barbini - Martedì 13 Febbraio 2018 ore 12:08

Per fortuna non sono solo canzonette. Tornando in tarda serata in albergo a San Telmo, città di Buenos Aires, in Argentina terra di migranti come nessun altra, dopo un pomeriggio che poi vi racconterò, mi è capitato di accendere il televisore.
Si vede solo Rai Uno e naturalmente Sanremo. Mentre mi lavo i denti sento l'inizio di un monologo di Favino che mi rapisce. E sono contento che in quel momento, forse, lo ascoltano anche milioni di argentini, di brasiliani, cileni di origine italiana, figli e nipoti di antichi migranti. Quasi non credo alle mie orecchie.
E' proprio Sanremo? Quello con tanti milioni di spettatori? Superlativo nella recitazione Favino. La storia è quella di un giovane «straniero» che cerca di trattenere uno sconosciuto incontrato per caso raccontandogli la storia di una pericolosa periferia metropolitana, tema ricorrente nelle opere di questo autore francese che conoscevo, specie nella sua più nota «Nella solitudine dei campi di cotone» dove una vittima e un carnefice si scambiano di continuo i ruoli. Favino (Koltès) parla per metafora, ma è molto facile capirlo, andarci dentro: ci sono spesso due personaggi che contrattano qualcosa che parte dal materiale e finisce con l’essere invece un bene spirituale, metti l’amore.
Favino (Koltès) non offre teoremi, non ha soluzioni né rivelazioni, non presenta il conto, la sua passione sta nel risvegliare emozioni e domande sul bisogno di stare insieme e di accettare l’Altro, chiunque sia. L'altro, il diverso da te.
Che magistrale lezione in un momento in cui l'Italia e l'Europa è attraversata da rigurgiti fascisti e razzisti. Ed ecco allora il mio pomeriggio in una periferia metropolitana, speso alla ricerca di quei migranti che in un altro continente, respinti a Nord da Donald Trump, vengono in Argentina per una speranza che somiglia a quella dei nostri nonni.
A villa miseria, questo è il nome, a pochi passi dalla stazione di Retiro, un pomeriggio di caldo appiccicoso, di quelli che solo qui, con l'umidità che mangia le ossa e il sudore che dilaga a chiazze sulla camicia. Qui ingombro all'inverosimile di uomini e cose. Vecchie carcasse di auto e lamiere su cui molti custodiscono e trasportano tutto ciò che hanno potuto racimolare nei loro giorni di stenti. Le donne che sopra i loro poncho consumati dal tempo e dall'uso, stendono magliette annerite o qualche Gorro e poi il poco che possono mettere in vendita. È qui che si concentrano decine di migliaia di diseredati, venuti via da zone ancora più povere del continente latino americano: la Bolivia, il Perù, il Nicaragua, l'Equador e da quale situazione più infame siano fuggiti è davvero difficile concepirlo.
Sopravvivono in stamberghe di lamiera prive di acqua potabile e fognature. Intorno rivoli di melma putrida, mucchi di rifiuti e cani spelacchiati.
È l'umanità che ci vergogniamo di guardare negli occhi, per non coltivare sensi di colpa, per non vedere minate molte delle nostre convinzioni.
E poi i bambini, a nugoli. Bambini che sulla strada presumibilmente ci vivono, bambini che a ogni passo ti sbucano davanti e ti strattonano da dietro, bambini che ti rincorrono per implorarti un'elemosina o per proporti il loro niente. Bambini di strada. Bambini da terra di nessuno.
Da loro non ti aspetteresti quei sorrisi impenetrabili, quegli sguardi senza mortificazione: però proprio per questo gli uni e gli altri sono altrettanti pugni allo stomaco.
Quel quartiere l'ho attraversato a piedi. Come tanti altri confini della mia vita. Fa bene attraversarli a piedi. Sentirli sotto i piedi. Se non altro per intenderli meglio. Sono i migranti del mondo che assomigliano molto a quegli italiani che sbarcarono alla Boca, tanti ma vicini anni fa.
Tito Barbini